Una luminosa assoluzione. Torre di fine di Gian Pietro Barbieri
- epicentriblog
- 20 nov 2020
- Tempo di lettura: 5 min

L’ultima raccolta poetica di Gian Pietro Barbieri, edita da Digressioni Editore, alla quale l’autore arriva dopo un quarto di secolo di pubblicazioni, ha due fuochi principali già programmaticamente contenuti nel titolo toponomastico che, mentre indica un luogo specifico nel comune di Eraclea (Ve), accenna al lettore attento da un lato alla priorità paesaggistica dei testi e delle attenzioni di Barbieri uomo e scrittore; dall’altro al destino di solitudine e di presidio che accomuna la torre di guardia e lo sguardo del poeta.
Quello di Barbieri è un discorso che prosegue da tempo, e che come un continuo riflusso deposita negli spazi della coscienza i detriti della riflessione. La poesia iniziale, in funzione di prologo, incomincia perciò con dei puntini di sospensione a segnalare quella che è sempre una ripresa, anche laddove si traveste da luogo inaugurale. Una ripresa di ricerca, dunque, ma non solo intellettuale e verbale, bensì di impegno fisico tanto che a prevalere sono proprio sensazioni di affanno e fatica, quasi a voler affermare senza cautele che la ricerca poetica a cui questo testo apre è innanzitutto testimonianza di un lavoro e di un dolore simili a quelli di un randagio che snasa d’attorno in cerca di cibo. È Fabio Franzin, nella sua introduzione, a parlare con efficacia di randagismo, illuminando una possibilità interpretativa sulla quale torneremo, ma che importa fin d’ora evidenziare perché conferma quella dicotomia suggerita prima: il randagio, come il ramingo, è di casa nel paesaggio che attraversa in solitudine.
La punteggiatura stessa di questo proemio, del resto, molto misurata, quasi assente, mira a replicare nelle lunghe gettate, nei parchi respiri, l’affanno dello svicolare continuo, dell’improvvisa sterzata; la pausa del cibo trovato, la pace della tana raggiunta. Mette conto rilevare come in questo testo augurale, vera chiave di lettura, il poeta che si svela in questo affanno, in questo lavoro in-finito, e che gira testimoniando di un mondo percepito solo per frammenti d’immagini irrisolte, sia presentato in terza persona; non è l’Io più in grado di assumersi la responsabilità assoluta della ricerca della verità, ma riconosce il proprio dire, e dunque sé stesso, racconto tra i racconti, senza tuttavia che questo valga a pacificarlo o a contentarlo.
Sono quattro le sezioni che compongono il volume, bilanciate sull’asse della differenza ambientale. Da un lato, Àncora acqua e Àncora collina parlano dell’ambiente naturale, inteso come paesaggio e, più soggettivamente, come luogo radicale, di provenienza e rifugio, come natura viva in cui a vivere e mostrarsi sono legami profondissimi, a volte irriflessi e impronunciabili. A seguire, Cani di città e Esistente niente abbandonano il territorio amico per inoltrarsi in un ambiente che è il risultato del processo di antropizzazione, un processo difficile, contraddittorio, in cui agisce una scarna, depauperata, volgare volontà di potenza cementizia e i cui risultati si misurano non già nell’epicità delle costruzioni, quanto nella conta delle macerie verso le quali tutto pare tendere.

Il luogo non ha i tratti frenetici di certa iconografia metropolitana contemporanea, attiva e tentacolare, e si configura piuttosto come luogo del dissesto, di possibili e sempre prossimi crolli, di anemici edifici isolati, in cui serve la vita (l’arcobaleno di bambini) a dare senso al tutto. In una simile scena, desolata e desolante, si muovono i cani da macerie che salveranno solo chi sa crollare / per rimanere / vivo. Il loro fiuto e la loro insistenza scaveranno e renderanno visibili in modo nuovo gli oggetti che popolano la città, le case; la città che crolla porta con sé i segni del passaggio umano, dell’esistenza fatta di materiali e cose e rotture e abbandoni (la tazza sbrecciata). Nell’ambiente urbano antropizzato, la verticalità orante degli alberi è sostituita da quella rimbrottosa, macilenta e morente dei palazzi, che sono domande/ammonticchiate voragini capaci di imporsi con un’ombra perpetua, slegatasi dalla circolarità del giorno che si rigenera e che lascia al poeta poche scappatoie: Da qui, da questo nostro buio/si risponde solo per immagini.
Non è certo la sede per una analisi dettagliata delle singole poesie, che pure suggerirebbero molti motivi interessanti; meglio sostare sui grandi temi sollevati a partire dal simbolismo acquatico che percorre le prime due sezioni, scorrendo poderosa in superficie o sottraendosi in nascondimenti sotterranei. Lo spazio naturale e quindi, di riflesso, poetico di questi testi ha come coordinate i fiumi Piave e Sile, il mare Adriatico che entrambi accoglie. Tra questi estremi l’acqua scorre, persiste in quell’eterno fluire che porta con sé il totale delle proprie emozioni e assieme lo strazio dell’inesistenza, che è soprattutto destinazione e incapacità di trattenere (i nomi, certo, ma con essi ogni memoria); l’acqua in forma di torrente anticipa il disastro di una contemporaneità che nel tutto presente lascia andare, come rifiuti, i ricordi, le tradizioni, i nomi, forse anche il linguaggio stesso, e si avvia al proprio niente futuro. Che sia torrente o fiume, l’acqua restituisce in queste due sezioni, immagini torbide, irrisolte, come se fossimo nel regno notturno del sogno, dove tutto è inconsistente e le mani, voraci, fameliche, terrorizzate, cercano invano di afferrare qualcosa. Il poeta è lì, vede, coglie, riecheggia, fa da cassa di risonanza, ma comprende che è inutile, che le voci e le parole non possono più dire niente all’aperto, all’orecchio dei passanti, ai contemporanei.
Nelle altre due sezioni l’acqua viva, fluente, vitale, si defila in due direzioni; o si conclude in spazi artificiali e immoti, arresa come piscina condominiale, ammutolita come lago ghiacciato; ovvero resta impigliata nella codificazione retorica, nei vari fingimenti immaginifici con cui il linguaggio si fa metafora: così l’isola cittadina, lo stagno urbano tra i palazzoni dove gracidano rane-strane umane, la luce che allaga, la vita interiore che è un acquario, il poeta che è nave alla deriva e le cui parole galleggiano nel silenzio.
Questo sfinimento retorico concorre a sottolineare l’altro grande tema del libro, un tema non certo nuovo ma che ciononostante continua a essere il banco di prova su cui la voce poetica si misura, riflettendo sul proprio statuto e sui propri strumenti: il rapporto tra e parole e il mondo. Lungo tutta la raccolta la posizione di Barbieri pare chiara: le forze del dire poetico vengono meno, soffocate dal dubbio che si possa davvero ancora dire qualcosa di significante. La caduta, primo testo della seconda sezione, è un visibile omaggio alla sempre presente figura di Andrea Zanzotto; si apre, apparentemente in antitesi al suo vecio parlar e al petèl, sostenendo che occorre un nuovo parlare, ma presto, dopo alcune circonvoluzioni linguistiche, ecco il rinnovato schermirsi del poeta che non ha più molto da dire e che riflette su cosa in fondo passa dirsi di questo “io” chiamato (chiamatosi) a parlare. È una poesia, come la successiva, dedicata all’autunno, stagione riflessiva per eccellenza, perché cangiante, contraddittoria, morente/vivente, vinosa, e simbolo dell’esistenza umana che può andare solo in una direzione (anch’io mi sfoglio nell’attesa).

Il linguaggio non solo è debole in sé, ma pare senta di dover disattendere alla propria funzione come, più avanti, suggerisce l’immagine del ponte, così stanco di essere ponte; c’è in questo tutta la spossatezza della comunicazione che vuole essere comunione, il tedio e la disillusione dell’uomo parlante; tutto il doloroso (e forse inane) lavorio necessario a farci vicini, a renderci l’uno all’altro prossimi, intendibili. Cosa può allora questo poeta che smette la corazza apodittica dell’Io e si sfa in più persone, si sbrana, si spezza come cocci di quello specchio su cui per troppo tempo ha guardato guardarsi? Ancorandosi, con un ultimo e decisivo sforzo, di nuovo a quella natura viva dalla quale aveva preso le mosse, e che riconosce come propria genitrice, scrivo come e perché un usignolo canta, la scrittura è platonicamente copia, e se pure a tratti si mostra come inutile segno, non può non accadere e perpetuarsi. Alla ricerca del nuovo nell’eterno, la soluzione trovata da Barbieri stupisce, pur nella palese ossequiosa reverenza a Zanzotto. Le ultime tre liriche sono in inglese, lingua franca mondiale, qui intesa forse come luogo neutro di ripartenza e, chissà, di semplicità. Quella semplicità luminosa e gioiosa che l’ultima poesia dispiega, ricorrendo all’immagine heideggeriana della radura.
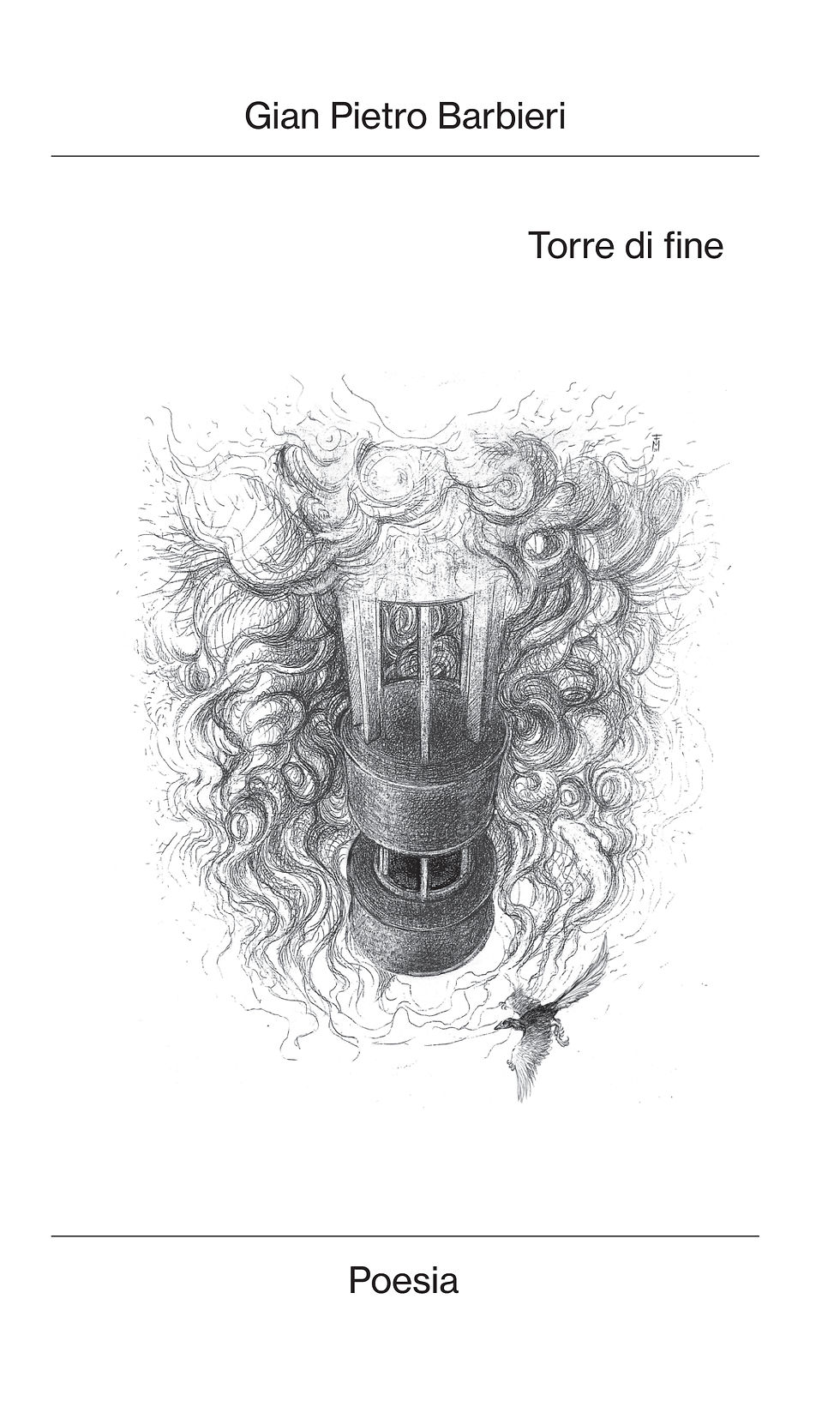
(The clearing)
A family of shadows
Sings silently, quite happy
Where the light reveals itself
There the never-ending end
begins




Commenti